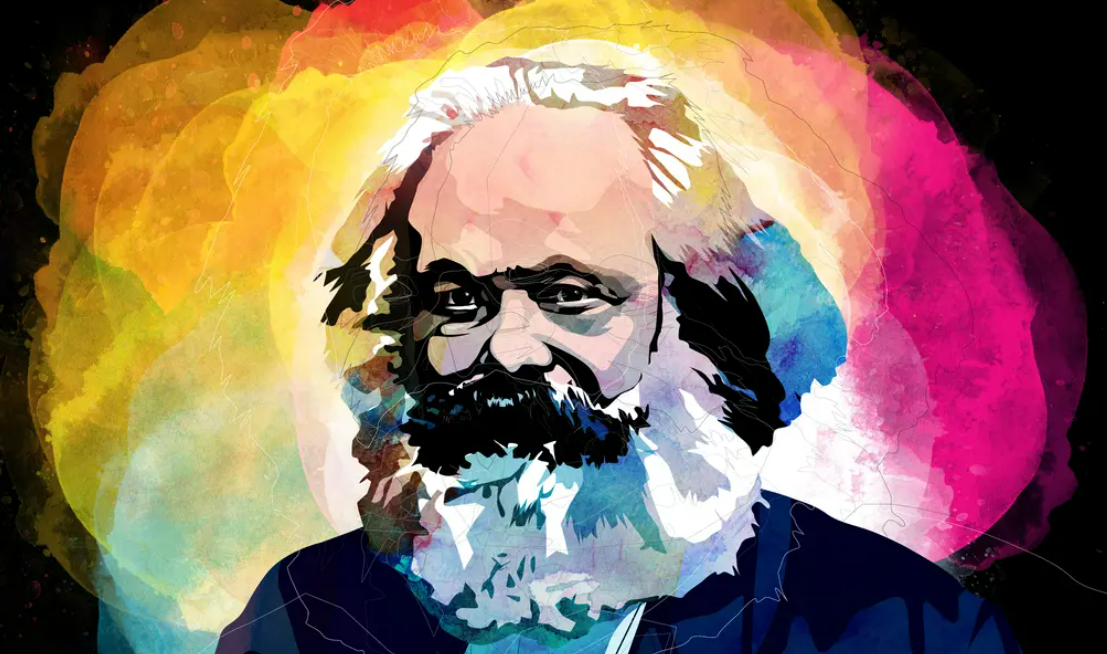di Fabio Di Lenola
Nelle conferenze del 1847 all’Associazione degli operai tedeschi di Bruxelles, pubblicate in seguito con il titolo Lavoro salariato e capitale, Marx definisce il salario come prezzo di un determinato tempo o di una determinata prestazione di lavoro, una merce dunque come le altre, che si scambia con il denaro del capitalista, necessario per sopravvivere, una “merce speciale, che è contenuta soltanto nella carne e nel sangue dell’uomo“. Ogni operaio è libero di venderla a questo o quello (a differenza dello schiavo o del servo della gleba), ma non è libero di non venderla “all’intera classe dei compratori, cioè la classe dei capitalisti, se non vuole rinunciare alla propria esistenza“. In Salario, prezzo, profitto del 1865 e nelle varie stesure del Capitale, Marx perviene a una definizione più rigorosa, distinguendo forza-lavoro o capacità di lavoro (“l’insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso di qualsiasi genere“) e lavoro erogato, come processo di ricambio organico con la natura nelle varie forme storiche (manifattura, grande fabbrica ecc.). Tale distinzione prevede la separazione iniziale e sempre rinnovata (accumulazione originaria) fra lavoratore e mezzi di produzione, cioè il “ libero “ rapporto salariale. Il salario è il prezzo della riproduzione della forza-lavoro (IL TEOREMA DELLA RIPRODUCIBILITÀ DEL CAPITALE DI SRAFFA, [per conoscenza o curiosità]) Questa è la differenza radicale con l’economia politica classica.
Mettendo per un attimo da parte Marx, possiamo definire il lavoro come, ad esempio, quello svolto dall’uomo. Lo stesso (uomo), in economia, viene definito come un fattore produttivo o forza produttiva (capitale umano), all’interno della catena di produzione stessa.
Secondo Marx, per forze produttive si intendono:
- gli individui che lavorano e costituiscono forza produttiva
- i mezzi di produzione, ovvero tecniche e macchinari
- le conoscenze tecniche e scientifiche
Accenniamo brevemente ad una definizione delle tre principali componenti del circuito della produzione.
Possiamo definire gli individui che lavorano e partecipano al processo produttivo come capitale variabile(quello investito nei salari dunque), e definiamo come capitale costante quello investito nei mezzi di produzione e nell’eventuale acquisto di materie prime (i cosiddetti mezzi di produzione).
Aggiungiamo alla catena di produzione, oltre al capitale costante ed a quello variabile, “le conoscenze tecniche e scientifiche” (nuovi modi di produrre o nuovi beni da produrre in sostituzione dei precedenti), in grado di modificare i cicli di produzione e la relativa capacità produttiva in un determinato momento.
Solitamente al progredire delle conoscenze tecniche/scientifiche, aumenta la capacità produttiva del ciclo di produzione.
I conflitti generati all’interno dell’economia capitalista danno luogo alla determinazione dei salari e dei prezzi e generano disoccupazione (l’esercito industriale di riserva secondo Marx, il tasso di disoccupazione naturale secondo gli economisti neoclassici).
Prendiamo ad esempio la descrizione del ciclo economico secondo Kalecki:
“Il lavoro appare ancora di grande attualità: se lo stimolo alla produzione fosse ottenuto riducendo i salari e aumentando la disoccupazione per aumentare i profitti, come prescritto dalle teorie neoclassiche dell’equilibrio, mancherebbe la domanda per collocare il maggiore prodotto. Sarebbe quindi necessario che i capitalisti spendessero in consumi e investimenti i loro profitti. Tuttavia, poiché non lo fanno o lo fanno comunque in una percentuale minima, si accumuleranno risparmi inutilizzati e i prezzi si ridurranno, facendo cadere nuovamente i profitti; si creerebbe così un circolo vizioso dal quale è possibile uscire solo con un maggiore intervento pubblico.”
LA DISOCCUPAZIONE
Se analizziamo le caratteristiche e il funzionamento dei mercati e del sistema capitalista ci possiamo accorgere di come essi non riescano a svolgere quel ruolo di “mano invisibile” (termine coniato da Adam Smith), che teoricamente viene loro attribuito, e che dovrebbe portare ad una piena efficienza delle economie di mercato.
La realtà,infatti,evidenzia l’esistenza di numerose e ricorrenti situazioni di crisi, ossia di dinamiche economiche caratterizzate da disoccupazione, inflazione e sottosviluppo. Queste dinamiche non sono altro che manifestazioni dell’instabilità delle economie di mercato e l’assoluta mancanza di un qualsiasi equilibrio o tendenza al naturale tasso di una qualunque variabile.
Con il termine “disoccupazione” ci riferiamo, essenzialmente, alla disoccupazione involontaria che è connessa, a sua volta, con il livello della domanda globale (o domanda aggregata).
Essa sorge quando vi sono lavoratori (potenziali) disposti ad occuparsi al tasso di salario vigente, ma la domanda di lavoro non è sufficiente per occuparli(nel mercato del lavoro, le imprese DOMANDANO lavoro e i lavoratori OFFRONO il loro lavoro…la prassi reale ci porta,a volte, a confondere le cose). In altre parole c’è una “quota” di capitale umano, di lavoratori, che nessuno vuole “acquistare” al “prezzo”(salario) attuale di mercato.
Possiamo quindi affermare, in questo caso, che l’offerta di lavoro è razionata(limitata). Oltre all’esempio sopra citato (disoccupazione involontaria), possiamo parlare di disoccupazione volontaria quando un lavoratore, per varie ragioni, non accetta un determinato salario quindi è volontariamente disoccupato, o non vuole proprio lavorare (magari non ne ha bisogno). In ultimo possiamo definire disoccupazione frizionale quella dovuta ad attriti, errori di calcolo, che causano squilibri temporanei fra domanda ed offerta di lavoro nelle varie specializzazioni ed aree. Per esempio parliamo di disoccupazione frizionale quando gli studenti universitari si laureano e cercano lavoro(quindi il passaggio dall’istruzione alla “produzione”), oppure anche quando qualcuno vuole cambiare lavoro(il tempo che intercorre tra i due impieghi è una “disoccupazione frizionale”)
Dalle ricerche condotte sul mercato del lavoro di diversi paesi, sono emerse quattro caratteristiche fondamentali della disoccupazione :
- il tasso di disoccupazione non è uniforme ma varia molto a seconda dell’età, della razza del grado di esperienza.
- nel mercato del lavoro vi è un notevole turnover , ossia i flussi in entrata e in uscita sono consistenti rispetto al numero assoluto degli occupati e dei disoccupati(in pratica le persone “entrano” ed “escono” da un lavoro ad un altro.
- il turnover è in larga misura legato alle fasi del ciclo economico, infatti i licenziamenti e i prepensionamenti aumentano nei periodi di recessione(come oggi per esempio e ne abbiamo nota su ogni giornale, mentre le dimissioni volontarie e le assunzioni aumentano nei periodi di espansione.
- In ogni periodo esiste un certo livello di disoccupazione, o se lo si indica come percentuale della forza lavoro, un determinato tasso di disoccupazione.
Ad esempio attualmente in Italia il tasso di disoccupazione si attesta intorno all ‘ 11% (primi dati 2013 stimati attorno al 12,8%).
Dietro questo dato di natura complessiva, tuttavia, si celano valori molto disomogenei, relativi a differenti segmenti della popolazione. Ad esempio, per i giovani al di sotto dei venti anni il tasso disoccupazione è molto più elevato che per gli adulti ; o ancora il tasso di disoccupati nelle regione settentrionali è minore rispetto a quello che si registra nelle regioni del centro-sud. È poi importante sottolineare come la disoccupazione “in età avanzata”sia quella più difficile da debellare; dai 40 anni in su, infatti, perdere un impiego, molto spesso significa rassegnarsi ad una vita di assoluta precarietà economica in impieghi sempre più ordinati verso il “lavoro nero” o l’illecito.
SALARIO, PREZZO E PROFITTO
PRODUZIONE E SALARI
Possiamo definire i salari come salari reali e salari nominali. Per salario nominale (o monetario) intendiamo la quantità di moneta che viene versata al lavoratore dipendente in cambio di una sua prestazione(la famosa “busta paga”). Per salario reale intendiamo il potere d’acquisto del salario nominale (quanti beni possiamo acquistare con un determinato salario nominale in base al livello generale dei prezzi…si fa una “specie” di media).
Di conseguenza il salario reale è pari al salario nominale diviso un indice dei prezzi. Per analizzare i salari, i profitti e i prezzi,e la formazione di essi all’interno del processo produttivo, partiamo dalla definizione classica di tali concetti, fissiamo due punti relativi a tale analisi:
- l’ammontare della produzione nazionale è qualcosa di fisso
- la somma dei salari reali è un importo fisso, è una grandezza costante
Tali concetti portano alla seguente conclusione, se la classe lavoratrice costringe la classe capitalista a pagarle, sottoforma di salario monetario, 5 euro invece dei 4 decisi dall’imprenditore (l’equilibrio naturale dei salari), quest’ultimo, in cambio del lavoro prestato da lavoratori, li pagherà (sotto forma di merci dato che parliamo di “salario reale”), il “valore” di 4 euro anziché 5.
E perché succederebbe questo? Con quale artifizio il capitalista è in condizione di dare per 5 euro, il valore in merci di 4 euro? Con l’aumento del prezzo delle merci che esso vende.
Secondo tale prospettiva dunque, l’aumento dei salari non porterebbe a nessuna modifica di un presunto equilibrio, anzi genererebbe soltanto una continua rincorsa inflattiva tra salari e prezzi, in quanto il profitto delle imprese sarebbe una variabile assolutamente esogena.
LA PROSPETTIVA ETERODOSSA E MARXISTA
Ma l’aumento dei prezzi e in generale la variazione di prezzi delle merci dipendono soltanto dalla volontà del capitalista? Oppure è necessario il concorso di determinate circostanze?
Se non è cosi, gli alti e bassi, le fluttuazioni incessanti dei prezzi di mercato diventano un enigma senza soluzione.
È un fatto incontestabile che la classe operaia considerata nel suo insieme, spende la maggior parte del suo salario in beni di prima necessità(Keynes calcolò che il lavoratore spendeva il 90% del suo salario ai suoi temi). Un aumento generale dei salari provocherebbe dunque un aumento delle domande di beni di prima necessità, e conseguentemente un aumento dei loro prezzi di mercato.
I capitalisti che producono tali beni, con l’aumento dei prezzi di mercato delle loro merci compenserebbero l’aumento dei salari. Ma che ne sarebbe dei capitalisti che non producono beni di prima necessità?
Essi non potrebbero recuperare tale effetto,derivante dalla caduta del saggio del profitto (se aumenta il salario e non aumentano i prezzi, il profitto del capitalista scende) , conseguente all’aumento generale dei salari, con un aumento dei prezzi delle loro merci, perché la domanda di queste merci (di lusso) non sarebbe aumentata.
Il loro reddito diminuirebbe, e di questo reddito dovrebbero spenderne di più per la stessa quantità di beni di prima necessità ma a prezzo più alto. E non sarebbe ancora tutto. Essendo diminuito il loro reddito, essi potrebbero spendere di meno anche per le merci di lusso, e quindi diminuirebbe la domanda reciproca delle loro merci rispettive. Come conseguenza di questa contrazione di domanda, il prezzo delle loro merci cadrebbe. Per essere più chiari :
In questi settori d’industria il saggio del profitto cadrebbe non soltanto in rapporto diretto all’aumento generale del livello dei salari, ma in rapporto all’azione combinata derivante da un aumento dei salari , dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e dalla caduta dei prezzi degli oggetti di lusso.
Quale sarebbe la conseguenza di questa differenza nei saggi di profitto dei capitali impiegati nei vari settori industriali? Capitale e lavoro si sposterebbero dai settori meno remunerativi a quelli più remunerativi.(Converrebbe di più ad entrambe le parti, al lavoratore che prenderebbe un salario maggiore ed al capitalista che troverebbe in quel settore un profitto maggiore)
Una volta compiuto tale processo nei diversi rami dell’industria, si ritornerebbe al saggio generale del profitto, poiché tutto questo spostamento aveva avuto origine da un semplice mutamento intervenuto nel rapporto fra la domanda e l’offerta delle varie merci, col cessare della causa dovrebbe cessare anche l’effetto e i prezzi dovrebbero ritornare al loro livello primitivo (il sistema torna in equilibrio).
La caduta del saggio del profitto, conseguente all’aumento dei salari, diventerebbe cosi generale, invece di rimanere limitata solo ad alcuni rami d’industria.
A seguito di tali movimentazioni, una parte maggiore della produzione esisterebbe ora sottoforma di beni di prima necessità e una parte minore sottoforma di beni di lusso.
L’aumento generale dei salari, non porterebbe dunque ad altro, dopo un turbamento temporaneo dei prezzi di mercato, che alla caduta generale del saggio del profitto, senza alcuna variazione durevole nel prezzo delle merci.
Se l’aumento dei salari venisse speso in oggetti che prima non facevano parte del consumo corrente degli operai, la domanda complessiva di merci, (domanda aggregata della classe salariata e dei capitalisti) quindi, non aumenterebbe e cambierebbero solo le parti costitutive di questa domanda.(la composizione interna della domanda aggregata, come appunto spiegato sopra, meno beni di lusso, più beni di prima necessità)
In conclusione: possiamo dire che se l’aumento dei salari fosse impiegato per acquistare tutti i prodotti, non si avrà nessun aumento dei prezzi.
Se l’aumento dei salari fosse impiegato solo per determinati prodotti di consumo, i prezzi aumenterebbero temporaneamente, fino a che lo spostamento e la riallocazione del capitale in settori più remunerativi, riporterebbe il livello dei prezzi a quello iniziale(per effetto della concorrenza; non converrebbe alzare troppo i prezzi ad una impresa, dato che un’altra impresa potrebbe acquisire i nostri clienti con un prezzo, per lo stesso bene o molto simile, inferiore rispetto alla prima impresa menzionata ). La teoria che lega l’aumento dei salari ad un conseguente aumento dei prezzi (ciò succederebbe perché l’aumento della domanda avviene sempre sulla base di una data quantità di produzione) non trova riscontri.
L’esperienza più elementare dimostra invece che un aumento della domanda in taluni casi lascia completamente invariati i prezzi di mercato delle merci, mentre in altri casi provoca una aumento temporaneo dei prezzi, al quale segue un aumento dell’offerta, che provoca di nuovo una caduta dei prezzi al loro livello precedente.
Ad un aumento dei salari corrisponde quindi una caduta nei profitti dei capitalisti(in una situazione di “concorrenza perfetta” nei mercati dei beni).
La quota salari dunque aumenterebbe e con essa la redistribuzione dei beni prodotti all’interno del ciclo produttivo.
Per quota salari intendiamo la quantità di beni che il lavoratore riesce ad acquistare una volta finito il ciclo produttivo.
Se il salario reale cresce più della produttività, i lavoratori si appropriano di una quota maggiore di prodotto, quindi la quota distributiva aumenta. Se il salario cresce meno della produttività allora la quota distributiva diminuisce.(è ciò che di fatto poi accade in Germania, quella che ci viene descritta come “l’esempio da seguire”)
SALARI E PREZZI
“I prezzi delle merci vengono decisi o regolati dai salari”
Olivier Blanchard (il Blanchard, edizioni il Mulino).
Cosa ci dicono gli economisti di stampo liberista? Che i prezzi delle merci dipendono anche dai salari, ma non solo.
Anche i profitti, il mark up,(tecnica per il calcolo del profitto del capitalista) concorrono a formare il prezzo di determinati beni.
Ma come si formano i prezzi? Innanzitutto dai salari.
Poi viene aggiunta ai prezzi una determinata percentuale di profitto e il gioco è fatto.
Supponiamo che i salari degli operai impiegati nella produzione di una merce ammontino a 10 euro. Se il saggio del profitto fosse del 100% il capitalista aggiungerebbe 1o euro al monte salari e il prezzo complessivo della merce salirebbe a 20. Ma una tale determinazione dei prezzi sarebbe semplicemente la loro determinazione sulla base dei salari! Se nel nostro caso, i salari salissero a venti euro il prezzo della merce salirebbe a 40, e cosi via.
È per questo che gli economisti neo classici sostengono come un dogma che i salari regolano i prezzi, trattando i profitti come semplici aumenti percentuali aggiunti ai salari. Per quanto riguarda i profitti essi affermano che sono determinati dalla concorrenza fra capitalisti, questa concorrenza può certamente rendere uguali i diversi saggi di profitto nei diversi settori industriali(da settore a settore, da agricolo ad automobilistico per esempio), oppure ridurli ad un livello medio, ma essa non potrà mai determinare questo livello stesso o il saggio generale del profitto.
Poiché i salari non sono altro che un termine per designare il prezzo del lavoro, possiamo concludere con ciò, che i prezzi delle merci sono determinati dal prezzo del lavoro. Poiché “prezzo” è valore di scambio (e quando dico valore intendo sempre valore di scambio ), espresso in denaro(moneta), la cosa si riduce a dire che il valore della merce è determinato dal valore del lavoro, oppure che il valore del lavoro è la misura generale del valore.
Ma allora come viene determinato a sua volta il valore del lavoro?
Qui arriviamo ad un punto morto. Si inizia affermando che il valore del lavoro determina il valore della merce e si termina dicendo che il valore della merce determina il valore del lavoro.
Ci aggiriamo dunque in un circolo vizioso che non ci porta a nessuna conclusione.
È evidente che se noi facciamo del valore di una merce qualsiasi, per esempio del lavoro, del grano, o di un’altra merce qualunque, la misura generale e il regolatore del valore, non facciamo altro che spostare la difficoltà, perché determiniamo un valore per mezzo di un altro valore, che a sua volta ha bisogno di essere determinato.
Cos’è il valore di una merce dunque? E come esso viene determinato?
A prima vista parrebbe che il valore di una merce sia una cosa del tutto relativa e che non si può fissare senza considerare una merce nei suoi rapporti con tutte le altre merci.
Quando parliamo di valore di scambio di una merce intendiamo le quantità relative nelle quali essa può venire scambiata con tutte le altre merci. Come sono regolati i rapporti secondo i quali le merci vengono scambiate tra loro?
Se prendiamo ad esempio il frumento, troveremo che un chilo di frumento si scambia in diverse e quasi innumerevoli proporzioni con altre merci.
Eppure poiché il suo valore resta sempre lo stesso, esso deve essere qualcosa di distinto e indipendente da queste diverse proporzioni dello scambio con altri articoli; inoltre se dico ad esempio che un chilo di grano, si scambia con una certa quantità di ferro, secondo un determinato rapporto, dico che il valore del grano e il suo controvalore sono uguali ad una terza cosa.
Tanto il grano quanto il ferro devono dunque, essere riconducibili a questa terza cosa, che rappresenta la loro misura comune.
Visto che valori di scambio delle merci, non sono che funzioni sociali di queste,e non hanno niente a che fare con le loro proprietà naturali, dobbiamo innanzitutto chiederci : qual è la sostanza sociale comune a tutte le merci?
È il lavoro. Per produrre una merce bisogna impiegarvi o incorporarvi una quantità determinata di lavoro, e non di semplice lavoro, ma di lavoro sociale (chi produce un oggetto per il proprio uso immediato, per consumarlo egli stesso, produce un prodotto ma non una merce. Come produttore che provvede solo a se stesso egli non ha nulla a che fare con la società. Ma per produrre una merce egli non deve soltanto produrre un articolo che soddisfi un bisogno sociale, ma il suo lavoro stesso deve essere una parte della somma totale di lavoro impiegato dalla società)
Se consideriamo le merci come valori, le vediamo esclusivamente sotto questo punto di vista, come valore sociale realizzato, fissato, o se volete, cristallizzato.
Sotto questo rapporto le merci possono distinguersi l’una dall’altra solo perché rappresentano una quantità maggiore o minore di lavoro. Ma come si misura la quantità di lavoro? Secondo il tempo che dura il lavoro , misurandolo in ore, in giorni, ecc..
Arriviamo dunque a questa conclusione : una merce ha un valore perché è una cristallizzazione di lavoro sociale.
La grandezza del suo valore, o il suo valore relativo, dipende dalla quantità maggiore o minore di sostanza sociale in essa contenuta, cioè dalla quantità relativa di lavoro necessaria alla sua produzione.
I valori relativi delle merci sono dunque determinati dalla corrispondenti quantità o somme di lavoro impiegate, realizzate, fissate in esse. Ad esse occorre poi aggiungere la quantità di lavoro anteriormente incorporata nella materia prima della merce, il lavoro impiegato per gli strumenti, le macchine, i fabbricati necessari per realizzare il lavoro.
I valori delle merci sono espressione diretta del tempo di lavoro impiegato per la produzione di esse.
Il prezzo dunque non è altro che l’espressione monetaria del valore.
Le oscillazione dei prezzi di mercato quindi, sono determinati da variazioni della domanda e dell’offerta.
IL PROFITTO (O PLUSVALORE)
Supponiamo ora che la produzione della quantità media di oggetti correnti necessari alla vita di un operaio richieda quattro ore di lavoro medio. Supponiamo inoltre, che quattro ore di lavoro medio siano incorporate in un valore di 5 euro.
In questo caso 5 euro sarebbero il prezzo o l’espressione monetaria del valore giornaliero della forza lavoro di quell’uomo.
Se egli lavorasse quattro ore al giorno, produrrebbe ogni giorno un valore sufficiente, per comperare quella quantità media di oggetti di cui ha bisogno quotidianamente. Ma il nostro uomo è un operaio salariato, perciò deve vendere la sua forza lavoro alle imprese.
Supponiamo che egli sia un filatore ; se l’operaio lavorasse quattro ore al giorno aggiungerebbe al cotone un valore di 5 euro al giorno. Questo valore che egli aggiunge giornalmente al cotone costituirebbe un equivalente esatto del salario, del prezzo, che egli riceve giornalmente per prestare lavoro presso l’impresa.
In questo caso però il capitalista non riceverebbe nessun plusvalore (profitto) o nessun sovraprodotto.
Torniamo al nostro filatore, abbiamo visto che per rinnovare la propria forza lavoro, deve produrre un valore giornaliero di 5 euro, pari a quattro ore di lavoro, ma ciò non lo rende incapace di lavorare 8 o 10 ore al giorno.
Prendiamo ad esempio che l’orario di lavoro sia pari a otto ore giornaliere.
Oltre alle quattro ore che gli sono necessarie per produrre l’equivalente del suo salario, il filatore dovrà dunque lavorare altre quattro ore, che chiameremo plusvaloro , e questo pluslavoro si incorporerà in un plusvalore e in un sovraprodotto.
il filatore quindi ha aggiunto, con il suo lavoro extra, il valore di 5 euro extra al cotone e produrrà una quantità maggiore di filo.
Dato che il lavoro del filatore appartiene al capitalista, quest’ultimo dunque anticipando un salario di cinque euro, riceverà in cambio il valore di 10 euro.
Se le imprese ripetono questo processo quotidianamente, anticiperanno ogni giorno 5 euro e ne intascheranno 10, di cui una metà sarà impiegata per pagare nuovi salari e l’altra metà formerà il plusvalore per il quale il capitalista non paga nessun equivalente.
È su questa forma di scambio tra capitale e lavoro che la produzione capitalista è fondata.
I prezzi delle merci sono dunque stabiliti in base al loro valore reale (le ore di lavoro cristallizzate durante la produzione della merce stessa) e il profitto delle imprese dipende dal plusvalore.
Bibliografia
– Olivier Blanchard, Macroeconomia (2011)
– Karl Marx, Il Capitale (1867)
– Karl Marx, Salario prezzo e Profitto (1865)
– Emiliano Brancaccio, Anti – Blanchard (2012)