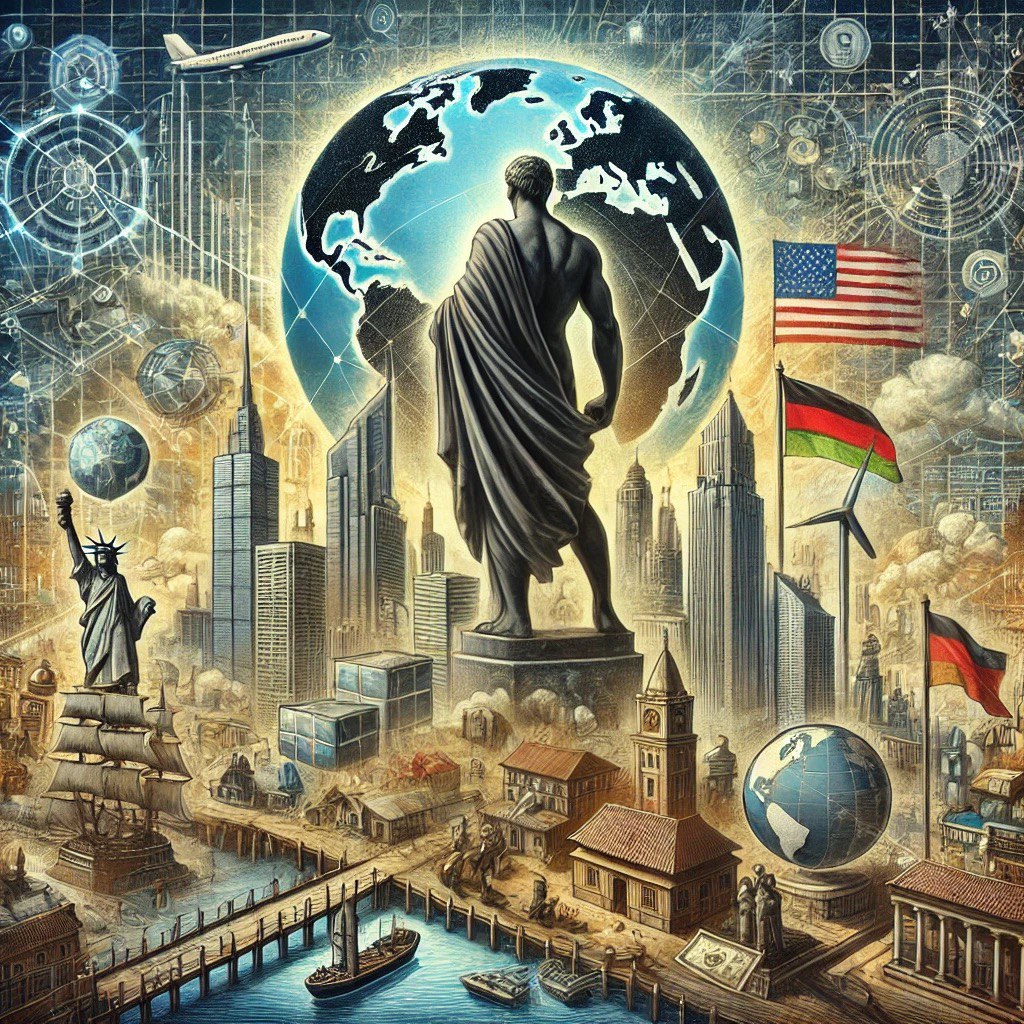di A. Scorrano
Negli ultimi anni, il fenomeno della globalizzazione – per decenni presentato come un processo ineluttabile e sostanzialmente benefico – è stato messo progressivamente sotto scacco da una serie di eventi geopolitici ed economici che ne hanno rivelato le fragilità strutturali. Le politiche protezionistiche dell’amministrazione Trump, culminate nell’imposizione di dazi su larga scala contro la Cina prima e contro numerosi partner commerciali poi, hanno rappresentato forse la più visibile contestazione di quel paradigma liberoscambista che sembrava aver conquistato un consenso quasi universale dopo la caduta del Muro di Berlino.
Queste politiche, proseguite e in alcuni casi ampliate anche nella nuova amministrazione Trump inaugurata nel gennaio 2025, non rappresentano semplicemente una deviazione temporanea dalla strada maestra della globalizzazione ma sono sintomatiche di un ripensamento più profondo delle strutture economiche internazionali sviluppatesi nell’ultimo mezzo secolo. Lo smantellamento delle catene globali del valore, l’enfasi sul reshoring delle produzioni strategiche e il tramonto del multilateralismo commerciale segnalano un cambiamento paradigmatico: la globalizzazione non appare più come un destino ineluttabile ma come una specifica configurazione storica dei rapporti di forza economici e geopolitici.
In questo contesto di transizione, diventa essenziale riscoprire quelle voci critiche che, controcorrente, avevano individuato le contraddizioni del modello globale ben prima che queste diventassero evidenti agli occhi di tutti. Tra queste, spicca quella del filosofo Costanzo Preve che ha elaborato una delle critiche più lucide e penetranti alla globalizzazione, interpretandola non come un processo neutro di integrazione economica e culturale ma come la forma contemporanea dell’imperialismo.
Di seguito si propone un’esplorazione del pensiero previano, mettendone in evidenza la sorprendente attualità alla luce degli sviluppi recenti. La sua analisi della globalizzazione come “imperialismo postmoderno”, caratterizzato da meccanismi di dominio più sofisticati e pervasivi rispetto al colonialismo classico, offre strumenti concettuali preziosi per comprendere le tensioni che attraversano il sistema internazionale contemporaneo.
Parallelamente, anche il contributo dell’economista e teorico politico Gianfranco La Grassa, che ha dialogato intellettualmente con Preve pur sviluppando una prospettiva originale, completerà questo quadro interpretativo. La sua analisi delle contraddizioni interne al sistema capitalistico globalizzato e della sua inevitabile evoluzione verso forme di competizione geoeconomica più esplicite arricchisce la nostra comprensione dei fenomeni in atto.
In un momento in cui le tensioni commerciali e geopolitiche, nonché le crisi multiple del sistema internazionale hanno reso evidente la fragilità dell’ordine liberale globale, rivisitare questi pensatori critici della globalizzazione ci permette non solo di decifrare meglio il presente ma anche di immaginare possibili futuri alternativi che superino tanto i limiti del globalismo neoliberista quanto le tentazioni reazionarie e autarchiche.
La globalizzazione come imperialismo postmoderno: l’analisi di Costanzo Preve e la sua attualità nel mondo contemporaneo
Costanzo Preve (1943-2013), filosofo collocabile nel filone dell’eterodossia marxiana, ha elaborato una delle critiche più penetranti alla globalizzazione, interpretandola non come un processo neutro di integrazione economica e culturale ma come la forma contemporanea dell’imperialismo. A differenza del colonialismo storico, fondato sull’occupazione militare e lo sfruttamento diretto delle risorse, la globalizzazione rappresenta, secondo Preve, un dominio più sofisticato e pervasivo, esercitato attraverso meccanismi finanziari, culturali e geopolitici. La sua analisi, sviluppata tra gli anni ‘90 e i primi decenni del 2000, rivela una sorprendente attualità, soprattutto alla luce delle recenti fratture del capitalismo globale, della delegittimazione delle istituzioni internazionali e della rinascita di conflitti interstatali che sembravano appartenere a un’epoca superata.
La natura imperiale della globalizzazione
Preve ha sostenuto che la globalizzazione non abbia affatto superato l’imperialismo – come invece affermano i teorici liberali – ma ne abbia piuttosto metamorfosato le forme. Se l’imperialismo classico si manifestava attraverso l’espansione territoriale delle potenze europee e la competizione interimperialista (come teorizzato da Lenin), quello contemporaneo opera attraverso l’egemonia del capitale finanziario transnazionale e l’imposizione di un modello unico di sviluppo economico e culturale.
Gli Stati Uniti, in questa prospettiva, non costituiscono semplicemente una nazione tra le altre ma il fulcro di un sistema imperiale informale che esercita la propria egemonia non solo tramite la forza militare (pur sempre presente, come dimostrano i conflitti in Medio Oriente o nei Balcani) ma soprattutto attraverso istituzioni (tra cui il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio), veri e propri strumenti di disciplinamento economico globale.
Questo imperialismo postmoderno non necessita di annettere formalmente territori, poiché controlla gli Stati attraverso una sofisticata strategia di coercizione finanziaria che si snoda anche attraverso le politiche monetarie e fiscali. In questo contesto è paradigmatico il ruolo svolto (sarebbe meglio dire, che gli è stato artatamente attribuito) dal debito pubblico (che di per sé rappresenterebbe uno strumento fisiologico di politica economica come sostenne l’economista William Vickrey nelle sue analisi sulle “fallace finanziarie”) il quale viene politicamente risemantizzato in termini morali di “colpa” e “virtù”.
Attraverso questa ridefinizione ideologica, il debito pubblico perde la sua originaria funzione di stabilizzatore sociale e motore d’investimento, trasformandosi invece in uno strumento per imporre condizionalità economiche e riforme strutturali.
Tale trasformazione ideologica stravolge la natura economica del debito pubblico – da strumento di stabilizzazione sociale e leva per gli investimenti a pretesto per imporre condizionalità economiche e riforme strutturali le quali, mentre accelerano i processi di concentrazione del capitale, ridefiniscono contestualmente i rapporti capitale-lavoro attraverso un paradigma di lotta di classe invertita: non più conflitto dal basso per la redistribuzione ma offensiva dall’alto per consolidare asimmetrie di potere. Parallelamente, determinano un allineamento coercitivo delle legislazioni nazionali agli standard dettati dagli interessi transnazionali, erodendo progressivamente non solo la sovranità economica degli Stati ma anche gli spazi di contrattazione democratica su cui si fondano i patti sociali del secondo dopoguerra.
Inoltre, a differenza del passato, questa nuova forma di imperialismo non si presenta come un progetto esplicitamente egemonico ma si cela dietro la retorica della libertà di mercato, dei diritti umani universali e dell’ineluttabilità del progresso globale. Preve, in alcune sue opere, smaschera questa narrazione, dimostrando come l’interventismo “umanitario” (dalla Yugoslavia alla Libia) sia in realtà funzionale alla destabilizzazione di aree geopolitiche refrattarie all’integrazione nel sistema neoliberale.
L’egemonia culturale e l’erosione della sovranità popolare
Un aspetto cruciale della critica previana è la dimensione culturale della globalizzazione. Preve riprende e rielabora la nozione gramsciana di egemonia, applicandola a un contesto in cui il dominio non si esercita più solo attraverso l’apparato statale o la coercizione diretta, bensì mediante la colonizzazione delle coscienze e la mercificazione di ogni sfera dell’esistenza umana. In quest’ottica, il neoliberismo non rappresenta semplicemente una dottrina economica, ma si configura come un vero e proprio sistema antropologico che promuove l’individualismo atomistico, il consumismo compulsivo e la frammentazione del tessuto sociale. Tale sistema si fonda su una forma avanzata di sussunzione reale del lavoro al capitale, in cui non solo i processi produttivi ma anche le relazioni sociali, i desideri e le soggettività vengono progressivamente incorporati nelle logiche del mercato. Il dominio neoliberale, dunque, si afferma come egemonia culturale totalizzante, capace di ridefinire in senso mercantile la stessa esperienza umana.
Questa egemonia culturale si traduce in una progressiva erosione della sovranità popolare e democratica. Gli Stati nazionali, un tempo luoghi di mediazione tra classi sociali e di redistribuzione della ricchezza, sono stati ridotti a meri esecutori delle direttive del capitale transnazionale, incapaci di proteggere i propri cittadini dagli effetti più devastanti della competizione globale. L’Unione Europea, in particolare, viene interpretata da Preve come un laboratorio avanzato di governance post-democratica, in cui le decisioni fondamentali sono delegate a organismi tecnocratici non elettivi (Commissione Europea, BCE) e in cui le politiche economiche sono subordinate al dogma della competitività globale, a detrimento del welfare e della coesione sociale.
Come Preve sottolinea in “Il popolo al potere. Il problema della democrazia nei suoi aspetti storici e filosofici” (2006), questo svuotamento della democrazia non è un effetto collaterale della globalizzazione ma la sua condizione necessaria: solo neutralizzando la volontà popolare è possibile imporre un modello economico che concentra la ricchezza nelle mani di élite transnazionali a scapito delle maggioranze.
La sinistra globalista e il suo divorzio dalle classi popolari
Uno dei contributi più originali e provocatori di Preve è la sua critica implacabile alla metamorfosi della sinistra contemporanea, accusata di aver abbandonato la lotta di classe per abbracciare un progressismo liberal-libertario che, paradossalmente, si rivela funzionale al dominio del modello neoliberista. Mentre la sinistra storica si batteva per la giustizia sociale e l’autodeterminazione dei popoli, quella odierna, secondo Preve, si è ridotta a promuovere un multiculturalismo superficiale e un individualismo libertario che non mettono in discussione le strutture fondamentali del potere economico.
Preve dimostra come la sinistra globalista sia diventata complice della finanziarizzazione dell’economia, avendo interiorizzato l’ideologia della “fine della storia” e accettato l’idea che non esistano alternative al mercato globale. Il suo compito si sarebbe così ridotto a mitigare gli effetti più destabilizzanti del capitalismo attraverso politiche identitarie o assistenzialiste che non ne intaccano la logica fondamentale.
Questa capitolazione ideologica ha determinato un progressivo distacco dalle classi popolari, sempre più attratte da movimenti sovranisti o populisti che, pur con tutte le loro contraddizioni e ambiguità, pongono almeno il problema della riconquista della sovranità nazionale come precondizione di qualsiasi politica emancipatoria. Il “tradimento delle élite progressiste”, come lo definisce Preve, ha lasciato un vuoto politico che è stato occupato da forze che, pur cogliendo istanze legittime di protezione sociale, le articolano spesso in forme regressive o xenofobe.
La crisi dell’ordine liberale e il ritorno della geopolitica
Se Costanzo Preve potesse osservare l’attuale scenario geopolitico, troverebbe numerose conferme ad alcune delle sue tesi più controverse e lungimiranti. La globalizzazione, un tempo presentata come un processo inarrestabile e benefico, mostra oggi evidenti segni di crisi strutturale. Fenomeni che fino a pochi anni fa sembravano appartenere al passato o a margini residuali della storia stanno ora tornando con forza al centro della scena.
Il ritorno della guerra interstatale, come nel caso del conflitto in Ucraina, delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale o dell’ennesima escalation israelo-palestinese, smentisce clamorosamente l’idea della “fine della storia” teorizzata da Fukuyama, rivelandone il carattere profondamente ideologico. Parallelamente, la fragilità delle catene globali del valore, messa in luce dalla pandemia e aggravata dalle nuove strategie di reshoring e friend-shoring adottate dalle grandi economie, segna una rottura con il modello integrato che ha dominato gli ultimi decenni.
In questo scenario prende forma una vera e propria rivolta delle “periferie” imperiali. Potenze come la Cina e la Russia sfidano apertamente l’egemonia occidentale, proponendo visioni alternative dell’ordine economico e politico. Anche le istituzioni sovranazionali, un tempo considerate garanti della stabilità e della cooperazione globale, attraversano una profonda crisi di legittimità: l’ONU, l’Unione Europea e altre entità analoghe appaiono sempre più distaccate dai bisogni reali delle popolazioni, percepite come strumenti di un establishment globale autoreferenziale.
Tutto ciò contribuisce all’emergere di un mondo multipolare, nel quale l’Occidente si trova, forse per la prima volta dall’epoca delle grandi conquiste coloniali, a dover fare i conti con potenze non-occidentali che ne contestano apertamente l’universalismo e l’eccezionalismo.
In questo contesto di crescente disordine globale, le riflessioni di Preve si rivelano quanto mai attuali. La sua critica alla globalizzazione come forma di dominio – mai neutrale né pacifica – aiuta a comprendere come, esaurita la sua spinta propulsiva, tale processo stia lasciando spazio a nuove configurazioni geopolitiche e a conflitti emergenti. La proposta di un “comunitarismo solidale” – che coniuga la difesa delle sovranità popolari con una critica radicale al capitalismo finanziario globalizzato – rappresenta ancora oggi una prospettiva stimolante per ripensare la politica in una fase storica segnata dalla transizione egemonica. Come affermava in “Elementi di politicamente corretto” (2010), solo attraverso la ricostruzione di comunità politiche coese, radicate e solidali è possibile contrastare la logica disgregante del capitale globale e immaginare forme nuove di cooperazione internazionale, non fondate sulla sopraffazione e sull’imperialismo.
Oltre l’unilateralismo globale
La lezione fondamentale di Preve è che la globalizzazione neoliberista non rappresenta il destino ineluttabile dell’umanità ma una fase storica determinata da specifici rapporti di forza economici, politici e culturali. La sua crisi contemporanea, manifestatasi prima con il collasso finanziario del 2007-2008 e poi con le tensioni geopolitiche attuali, apre spazi per immaginare alternative che, senza cadere nel nazionalismo reazionario o nel protezionismo autarchico, sappiano coniugare giustizia sociale, sovranità democratica e un nuovo internazionalismo fondato sul rispetto reciproco tra nazioni libere.
In un mondo sempre più frammentato e conflittuale, il pensiero di Preve, con la sua critica implacabile tanto del capitalismo globale quanto delle sue alternative illusorie, offre strumenti critici indispensabili per decifrare le contraddizioni del nostro tempo e per ricostruire, dalle macerie dell’ordine liberale, una politica autenticamente emancipatoria.
L’analisi di Gianfranco La Grassa: globalizzazione, gerarchie di potere e la crisi dello Stato nazionale
Per completare il quadro critico offerto da Costanzo Preve, è necessario integrare la prospettiva di Gianfranco La Grassa, il cui approccio alla globalizzazione si concentra sulle dinamiche di potere tra Stati e sulla metamorfosi del capitalismo in un’epoca di apparente dominio finanziario transnazionale. Mentre Preve ha analizzato la globalizzazione come una forma di imperialismo culturale ed economico, La Grassa ne esamina le strutture geopolitiche, evidenziando come gli Stati nazionali, lungi dall’essere superati, rimangano attori fondamentali in un sistema gerarchico di subordinazione.
La globalizzazione come sistema di potere gerarchizzato
La Grassa rifiuta la narrazione secondo cui la globalizzazione avrebbe dissolto gli Stati nazionali a vantaggio di un’entità sovranazionale impersonale. Al contrario, sostiene che il potere si sia riorganizzato in una struttura piramidale, con gli Stati Uniti al vertice e una serie di nazioni subalterne disposte lungo una scala di influenza decrescente. Questo sistema non è statico ma dinamico: le alleanze si ridefiniscono, le sfere di competizione si espandono e i rapporti di forza mutano, sebbene la supremazia statunitense permanga come perno dell’ordine globale.
La sua critica alla tesi della “fine degli Stati nazionali” è particolarmente rilevante oggi, alla luce del ritorno della geopolitica come strumento di analisi privilegiato. La guerra in Ucraina, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e la frammentazione del sistema economico globale dimostrano che la competizione tra Stati non è affatto scomparsa ma si è semplicemente adattata a nuove forme. La Grassa osserva che, mentre il capitale finanziario opera su scala globale, esso non agisce in un vuoto politico: è sempre legato a élite nazionali che, pur essendo interconnesse, rispondono a logiche di potere radicate in specifici contesti statali.
L’illusione della sovranazionalità e il ruolo dell’Europa
Un punto cruciale dell’analisi di La Grassa riguarda l’Unione Europea, che egli considera non come un’entità autonoma ma come un progetto funzionale alla perpetuazione dell’egemonia statunitense. A differenza di Preve, che vede nell’UE un laboratorio di governance post-democratica, La Grassa la interpreta come una struttura di subordinazione politica ed economica, in cui le élite europee agiscono da intermediarie tra il capitale transnazionale e i propri apparati statali. L’euro, le politiche di austerity e il modello neoliberale imposto dalla Troika qualche anno fa non sono semplicemente il frutto di una deriva tecnocratica ma il risultato di una precisa gerarchia di potere in cui l’Europa occupa una posizione subalterna.
Questa lettura è confermata dalle recenti crisi europee: dalla gestione del debito greco alle divergenze tra Stati membri sulle politiche energetiche e migratorie, emerge chiaramente che l’UE non è un soggetto unitario ma un campo di battaglia in cui si scontrano interessi nazionali e pressioni esterne. La Grassa sottolinea che, in assenza di una vera autonomia strategica, l’Europa è condannata a oscillare tra l’acquiescenza agli Stati Uniti e una frammentazione interna sempre più marcata.
La crisi della lotta di classe e l’ascesa dei conflitti interstatali
Mentre Preve ha denunciato la deriva globalista della sinistra, La Grassa approfondisce il declino della lotta di classe come paradigma centrale della conflittualità sociale. Secondo la sua analisi, il marxismo tradizionale ha fallito nel prevedere l’evoluzione del capitalismo perché ha sopravvalutato il ruolo del proletariato come soggetto rivoluzionario e sottovalutato la persistenza delle rivalità geopolitiche. Oggi, i conflitti non si giocano più lungo l’asse verticale borghesia-proletariato ma su quello orizzontale Stati vs Stati, con alleanze trasversali che sfuggono alle categorie classiste.
Questa prospettiva aiuta a spiegare fenomeni contemporanei come:
- la rinascita di movimenti sovranisti, che, pur privi di una chiara agenda anticapitalista, pongono il tema della riconquista della sovranità nazionale come prerequisito per qualsiasi politica emancipatoria.
- l’ascesa della Cina come potenza alternativa agli Stati Uniti, che sfida l’egemonia occidentale non attraverso una rivoluzione socialista ma tramite un capitalismo di Stato inserito in logiche di competizione globale.
- la crescente militarizzazione dell’economia, con sanzioni, guerre commerciali e tecnologie critiche diventate strumenti di guerra geopolitica.
Autonomia nazionale e multipolarismo: una via d’uscita?
La Grassa non si limita a una critica del presente ma avanza una proposta strategica: in un mondo sempre più multipolare, l’unica via per sfuggire alla subordinazione è la riconquista dell’autonomia nazionale. Questo non significa abbracciare un nazionalismo reazionario ma costruire alleanze alternative che rompano con la dipendenza dagli Stati Uniti. Per l’Italia e l’Europa, ad esempio, ciò implicherebbe una riorganizzazione delle relazioni internazionali, con un avvicinamento a potenze come la Russia (prima della guerra in Ucraina che ha stravolto le prospettive) o la Cina, non per adesione ideologica ma per bilanciare l’egemonia americana.
Tuttavia, La Grassa è consapevole delle contraddizioni di questo approccio. Il multipolarismo non garantisce automaticamente maggiore giustizia sociale ma può aprire spazi per politiche meno vincolate ai diktat del capitale globale. La sua riflessione si collega a quella di Preve nel riconoscere che, senza una ricomposizione del tessuto sociale e una ridefinizione della sovranità popolare, ogni tentativo di autonomia rischia di ridursi a un mero riposizionamento geopolitico privo di contenuto trasformativo e liberatorio.
Tra crisi della globalizzazione e nuovi conflitti
L’integrazione delle analisi di Preve e La Grassa offre una visione completa della globalizzazione come fenomeno complesso, in cui l’imperialismo economico e l’egemonia culturale si intrecciano con le gerarchie di potere tra Stati. Se Preve ha smascherato la retorica neoliberista e l’erosione della democrazia, La Grassa ha mostrato come il sistema globale sia tutt’altro che privo di centri di potere ma anzi strutturato attorno a precise relazioni di dominio.
Oggi, con il declino dell’ordine liberale e l’ascesa di nuovi attori, le loro intuizioni si rivelano profetiche. La globalizzazione non è morta ma è entrata in una fase di crisi in cui le sue contraddizioni stanno esplodendo. Il compito della critica radicale, come suggeriscono entrambi gli autori, non è rimpiangere un passato idealizzato né abbracciare acriticamente il multipolarismo ma elaborare strategie che uniscano la lotta per l’autonomia nazionale alla costruzione di alternative economiche e sociali più giuste. In un’epoca di transizione egemonica, il loro pensiero rimane una bussola indispensabile per orientarsi tra le rovine del presente e le possibilità del futuro.